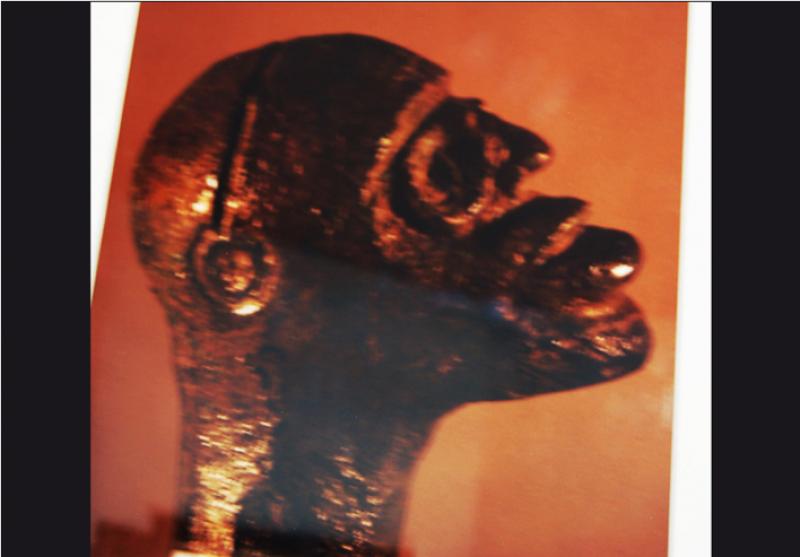La definizione di “sardi negroidi” compare nella letteratura antropologica tra Otto e Novecento per indicare i più antichi abitatori della Sardegna, sulla base di alcune caratteristiche fisiche rilevate nei reperti preistorici. Oggi questo termine è considerato obsoleto e riduttivo, ma resta utile come riferimento storico per comprendere come veniva interpretata l’origine dei primi uomini dell’isola. Le ricerche archeologiche e paleontologiche moderne hanno invece chiarito che le tracce più antiche risalgono al Paleolitico inferiore, con ritrovamenti significativi nelle grotte di Dorgali e nel territorio del Golfo di Orosei.
- LEGGI ANCHE: Il Canto a Tenore

🌋 Sardegna primordiale — dagli elementi al primo popolamento
La Sardegna custodisce i lembi geologici più antichi d’Italia, eppure fu tra le ultime terre a essere esplorate e stabilmente abitate dall’uomo.
🏞️ Isola selvaggia e inospitale
Per decine di millenni, l’insularità e la natura aspra ne hanno scoraggiato la presenza umana. L’Isola si presentava
prevalentemente montuosa e collinare, ricoperta da fittissima boscaglia e sferzata da venti impetuosi che rendevano
ostile la vita e i collegamenti.
🌧️ Acqua, ghiaccio e fuoco
Le fasi glaciali, pur interessando direttamente l’Europa nord-orientale, influenzarono anche il Mediterraneo:
in Sardegna aumentarono piovosità e instabilità climatica. L’attività vulcanica era ancora viva e gli incendi, frequenti,
modellavano il paesaggio insieme all’erosione di acqua e vento.
Dalla solitudine al popolamento
Solo quando le condizioni ambientali e le rotte di navigazione migliorarono, l’Isola iniziò a essere esplorata
e poi abitata stabilmente, aprendo la lunga storia del rapporto tra l’uomo e la Sardegna.
Acqua, ghiaccio e fuoco: gli elementi primordiali della Sardegna
Durante le epoche glaciali, sebbene i ghiacci interessassero soprattutto le regioni nord-orientali d’Europa, i loro effetti si riflettevano anche sul Mediterraneo. La Sardegna era caratterizzata da abbondanti precipitazioni, da un’attività vulcanica ancora viva e da incendi frequenti che modellavano il paesaggio.

Le prime presenze umane in Sardegna
L’arrivo dell’uomo in Sardegna viene fatto risalire al Paleolitico Inferiore, epoca conclusa circa 300.000 anni fa, quando l’isola non era ancora un’isola ma parte integrante della massa continentale. In quei tempi, infatti, i bassi livelli del mare consentivano il passaggio di gruppi umani e di fauna attraverso ponti naturali di terra che collegavano il Tirreno con la penisola italiana e l’Europa.
Le tracce più antiche
Le testimonianze di questa fase non sono numerose, ma alcuni ritrovamenti litici indicano che anche la Sardegna fu interessata dalle prime ondate di popolamento preistorico. Queste comunità arcaiche vissero in un ambiente selvaggio, sfruttando le risorse naturali e adattandosi a un territorio difficile ma ricco di acqua, selci e ripari naturali.
A caccia in Sardegna
Mentre in Africa, nella penisola Iberica e in quella Italica la presenza dell’uomo era già consolidata, i primi gruppi umani che raggiunsero la Sardegna, da cui deriverebbero i sardi negroidi, arrivarono probabilmente dal continente africano, spinti dalla ricerca dei grandi mammiferi che ancora popolavano l’isola.
I grandi mammiferi della Sardegna preistorica
Tra le specie più rappresentative ricordiamo:
l’orso,
alcune specie di scimmie,
l’elefante nano, tipico della fauna insulare.
Il ruolo della Corsica come ponte naturale
Secondo alcune ipotesi, la Corsica avrebbe rappresentato una via di accesso alternativa, grazie ai collegamenti naturali con il Golfo Ligure e quello di Lione. A supporto di questa teoria vi sono i più antichi reperti di presenza umana ritrovati nell’isola di Santo Stefano, nell’Arcipelago della Maddalena.
🏹 A caccia in Sardegna
In Africa, nella penisola Iberica e in quella Italica la presenza dell’uomo era già diffusa, ma i primi cacciatori che
giunsero in Sardegna arrivarono probabilmente dal continente africano, alla ricerca dei grandi mammiferi che popolavano
ancora l’isola.
🐘 I grandi mammiferi della Sardegna preistorica
- Orso
- Scimmia
- Elefante nano
🌊 La Corsica come ponte naturale
Alcune fonti ipotizzano un arrivo anche dalla Corsica, che avrebbe fatto da collegamento con il Golfo Ligure e
quello di Lione. A conferma di ciò vi sono i più antichi reperti di presenza umana nell’isola di Santo Stefano,
nell’Arcipelago della Maddalena.

- LEGGI ANCHE: Il Ramo nord della Grotta del Bue Marino
- LEGGI ANCHE: La spiaggia di Tziu Santoru, Dorgali
🗿 A Dorgali la più antica testimonianza dell’Uomo in Sardegna
Le uniche tracce che certificano la presenza dell’uomo in Sardegna già dal Paleolitico Inferiore
(circa 2,5 milioni di anni fa) furono rinvenute nel 1955 lungo la costa di Dorgali.
I reperti litici provengono dalla Grotta di Ziu Santoru, a nord della più celebre
Grotta del Bue Marino, e da alcune cavità della Codula di Luna,
il grande canyon che ha dato origine alla spiaggia di Cala Luna.
- Guarda anche il sito del Museo Archeologico di Dorgali
I reperti recuperati a Dorgali
Il rinvenimento più importante del Paleolitico in Sardegna si deve a una campagna di scavi condotta nel 1955 dal paleontologo Alberto Carlo Blanc, figura di spicco negli studi sulla preistoria italiana. In territorio di Dorgali furono ritrovati un focolare con pezzi di carbone e ossa bruciate di megaceros cazioti, un cervo endemico dell’isola, datati a circa 150.000–120.000 anni fa.
La scoperta, avvenuta presso la Grotta di Ziu Santoru, trova riscontro anche in altri reperti coevi provenienti dalla Grotta di San Giovanni, sempre nel territorio dorgalese, confermando il ruolo del Golfo di Orosei come culla delle più antiche testimonianze umane in Sardegna.
🐘 Il Mammuth sardo (Mammuthus lamarmorae)
Il Mammuthus lamarmorae, conosciuto come Mammut sardo,
visse in Sardegna e Corsica durante il Pleistocene
(2,58 milioni – 11.700 anni fa). Era un pachiderma dalle dimensioni ridotte,
unico nel suo genere in Italia.
📏 Un gigante in miniatura
Alto appena 150 cm al garrese, era molto più piccolo dei suoi antenati,
come il Mammuthus trogontherii (fino a 5 m), e anche degli elefanti attuali:
3,7 m in Africa e 3,5 m in Asia.
📍 Resti fossili in Sardegna
- Alghero – località Tramariglio
- Penisola del Sinis – Capo San Marco
- Gonnesa – Funtana Morimenta (frammenti ossei completi)
🏛️ Dove vederlo oggi
I calchi delle ossa del Mammut sardo sono esposti presso il
Museo PAS di Carbonia, testimoniando la storia di un animale endemico
e ormai estinto.
- LEGGI ANCHE: IL MAMMUTH SARDO
- Guarda anche il sito del Museo Pas di Carbonia

L’oro sardo, l’ossidiana
Dopo aver sviluppato le prime forme di adattamento ambientale e comunità stabili, l’uomo sardo entrò in contatto con le altre popolazioni del Mediterraneo grazie allo sfruttamento e al commercio dell’ossidiana, il “vetro vulcanico” che in Sardegna era particolarmente abbondante.
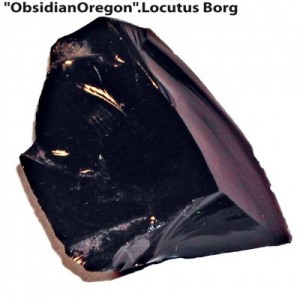
La merce che ruppe l’isolamento
L’ossidiana non fu solo una risorsa economica, ma anche uno strumento di evoluzione culturale. La sua lavorazione e il suo commercio permisero ai Sardi di superare l’isolamento geografico e avviare scambi con genti lontane.
Il Monte Arci, miniera a cielo aperto
Dietro il Golfo di Oristano, tra lagune pescose e zone ricche di selvaggina, si erge il Monte Arci. A soli dieci chilometri dal mare, questa montagna custodiva i più ricchi giacimenti di ossidiana del Mediterraneo. Nei filoni rocciosi e nei greti dei torrenti si trovavano enormi quantità di globuli e ciottoli che venivano trasformati in armi e utensili dal Neolitico.
In Sardegna i giacimenti più ricchi del mediterraneo
In Sardegna erano attivi quattro principali giacimenti, tra cui il più importante fu quello di Roja Cannas – Uras. Essi erano collegati a oltre 70 centri di raccolta e lavorazione, tra cui il più vasto si trovava a Sa Mitza de sa Tassa.
Grazie all’ossidiana, la Sardegna divenne un nodo commerciale paragonabile ai moderni traffici di carbone o petrolio. Il mercato si estendeva dalla Provenza alla Liguria, fino alla Sicilia e all’Italia meridionale. Questo fenomeno proiettò l’isola al centro di una vasta rete di rapporti economici, politici e culturali, aprendo i primi abitanti a nuove interazioni con il mondo mediterraneo.
- Guarda anche il sito del GeoMuseo del Monte Arci “Stefano Incani”