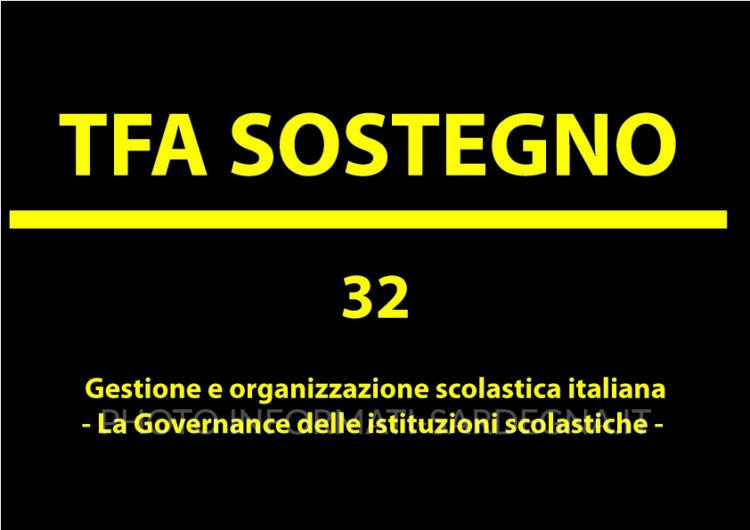Cos’è la gestione e organizzazione scolastica o governance scolastica
La governance scolastica è l’insieme dei processi di direzione, gestione e coordinamento attraverso cui una scuola italiana organizza la propria attività educativa, amministrativa e relazionale.
In altre parole, indica come la scuola viene “governata”, ovvero chi prende le decisioni, come vengono gestite le risorse e quali soggetti partecipano alla vita dell’istituto.
Il termine governance si distingue da governo: mentre quest’ultimo rimanda a un potere centralizzato, la governance sottolinea la partecipazione condivisa tra più attori — dirigenti, docenti, famiglie, studenti e territorio.
Guarda anche TFA SOSTEGNO 31 – Valutazione ed Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione: disabilità, DSA e BES
La villa sommersa del Capocentrale della diga di Santa Chiara:
memoria e mistero nel Lago Omodeo

Elenco degli argomenti:
- La dirigenza scolastica: il cuore della governance
- Gli organi collegiali: la partecipazione democratica
La dirigenza scolastica: il cuore della governance
Al vertice della governance scolastica italiana si trova il dirigente scolastico, figura chiave introdotta con l’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999).
Il dirigente:
rappresenta legalmente l’istituto;
coordina le attività didattiche, organizzative e amministrative;
valorizza le risorse umane e professionali del personale;
cura i rapporti con enti locali, famiglie e comunità;
assicura la qualità dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di sicurezza e trasparenza.
Il suo ruolo è di tipo manageriale e pedagogico insieme: gestisce le risorse ma al tempo stesso orienta la scuola verso la sua missione educativa.
Il duplice ruolo del dirigente scolastico: manager e guida pedagogica
Nella governance scolastica italiana, il dirigente scolastico riveste un duplice ruolo: manageriale e pedagogico.
Da un lato, come manager, il dirigente è responsabile della gestione strategica e organizzativa della scuola: coordina il personale, gestisce le risorse finanziarie, pianifica le attività e garantisce il rispetto delle norme. In questa dimensione, il dirigente agisce con un approccio manageriale moderno, orientato all’efficienza, alla trasparenza e alla valorizzazione del capitale umano.
Dall’altro lato, il dirigente ha una funzione pedagogica: è il punto di riferimento educativo e culturale dell’istituto. Promuove l’innovazione didattica, sostiene la formazione dei docenti e favorisce un clima scolastico inclusivo, collaborativo e motivante.
In questo senso, non è soltanto un amministratore, ma un leader educativo capace di coniugare visione pedagogica e capacità gestionale.
Grazie a questa doppia competenza, la dirigenza scolastica diventa il motore della qualità formativa e organizzativa della scuola, assicurando coerenza tra i principi educativi e le strategie di gestione.
Manager scolastico e manager aziendale: due ruoli diversi con obiettivi comuni
Anche se entrambi condividono competenze gestionali e capacità di leadership, il manager scolastico e il manager aziendale operano in contesti profondamente diversi.
Il manager scolastico, o dirigente scolastico, gestisce un’istituzione educativa pubblica o paritaria. Il suo obiettivo principale non è il profitto, ma il successo formativo e il benessere degli studenti. Lavora per migliorare la qualità dell’insegnamento, favorire l’inclusione e valorizzare le risorse umane, mantenendo sempre una visione pedagogica e sociale.
Il manager aziendale, invece, agisce in un contesto economico e competitivo. Il suo compito è massimizzare la produttività e i risultati finanziari dell’impresa, coordinando strategie di mercato, marketing, risorse e innovazione per raggiungere obiettivi di profitto e crescita.
La differenza fondamentale, quindi, sta nella finalità: il manager aziendale punta al rendimento economico, mentre il manager scolastico guida un’organizzazione educativa basata su valori, conoscenza e sviluppo umano. Entrambi, tuttavia, condividono la necessità di una leadership efficace, capace di motivare i team e garantire risultati concreti nei rispettivi ambiti.
Dirigente scolastico e preside: cosa è cambiato dopo la riforma dell’autonomia
Prima della riforma dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999 e D.Lgs. 165/2001), la figura che guidava le scuole italiane era quella del preside, un funzionario con compiti principalmente amministrativi e di vigilanza. Il preside si occupava dell’organizzazione interna, applicava le direttive ministeriali e garantiva il rispetto delle norme, ma aveva un potere decisionale limitato: la scuola era ancora fortemente dipendente dal Ministero e dalle autorità esterne.
Con l’introduzione dell’autonomia scolastica, il preside è diventato dirigente scolastico, acquisendo una nuova identità professionale basata su responsabilità manageriali e gestionali.
Oggi il dirigente:
gestisce le risorse umane e finanziarie dell’istituto;
coordina il personale docente e ATA;
stipula contratti e progetti;
rappresenta legalmente la scuola;
e soprattutto, definisce la strategia educativa e organizzativa in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
In sintesi, mentre il preside era un amministratore-esecutore delle direttive ministeriali, il dirigente scolastico è un leader autonomo, responsabile della qualità, dell’innovazione e della visione educativa della scuola.
Dirigente scolastico per concorso non per nomina
Il dirigente scolastico è una figura tecnica e professionale, che accede al ruolo attraverso un concorso pubblico nazionale bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).
Per diventare dirigente scolastico è necessario:
essere docente di ruolo con almeno 5 anni di servizio;
superare prove scritte, orali e una formazione dirigenziale finale;
essere inseriti in graduatoria e assegnati a una sede in base al punteggio ottenuto.
Il dirigente, una volta nominato, non dipende dalla politica, ma esercita la propria funzione nell’ambito dell’amministrazione pubblica, con autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, come stabilito dal D.Lgs. 165/2001.
È quindi un funzionario dello Stato, non un incaricato politico: risponde alle leggi e agli obiettivi del sistema scolastico nazionale, non ai partiti o agli enti locali.
In sintesi:
Il dirigente scolastico è un professionista della pubblica amministrazione, selezionato per merito e competenza, non per appartenenza politica.
Gli organi collegiali: la partecipazione democratica
Accanto al dirigente scolastico operano gli organi collegiali, che rappresentano la dimensione partecipativa della governance scolastica.
Tra questi troviamo:
Il Collegio dei docenti, che progetta e coordina l’attività didattica;
Il Consiglio di istituto, formato da docenti, personale ATA, genitori e studenti (nelle scuole secondarie), che delibera sugli aspetti organizzativi e finanziari;
Il Consiglio di classe o di interclasse, che segue da vicino il percorso educativo di ciascun gruppo di studenti.
Questi organi assicurano trasparenza, corresponsabilità e pluralismo nelle decisioni, elementi centrali della governance partecipata.
Il ruolo del DSGA e del personale amministrativo
La gestione amministrativa e contabile è affidata al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che collabora con il dirigente per garantire efficienza, correttezza e rispetto delle procedure.
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) completa il quadro, assicurando il funzionamento quotidiano della scuola.
Famiglie, studenti e territorio: la rete della scuola autonoma
La governance scolastica italiana non si limita agli organi interni.
Grazie all’autonomia scolastica, ogni istituto può costruire relazioni con il territorio, promuovendo collaborazioni con:
enti locali e regioni;
associazioni culturali e sportive;
università e imprese;
organizzazioni del terzo settore.
In questo modo la scuola diventa centro di comunità, aperta, inclusiva e in dialogo con la società.
Conclusione: una governance per una scuola partecipata e responsabile
La governance scolastica italiana rappresenta un modello di gestione partecipata e responsabile, in cui dirigenti, insegnanti, famiglie e studenti condividono obiettivi e decisioni.
Una buona governance garantisce trasparenza, efficacia educativa e coesione sociale, rafforzando il ruolo della scuola come luogo di crescita e cittadinanza attiva.