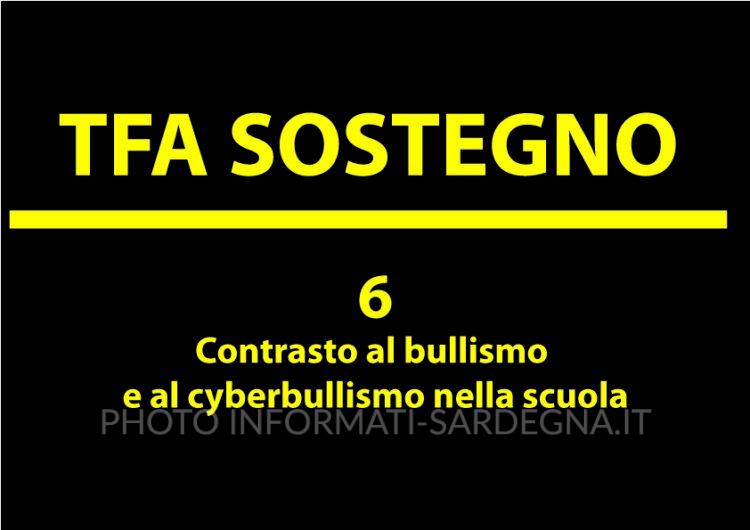Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo rappresenta oggi una vera emergenza sociale ed educativa in Italia. Sempre più spesso studenti e adolescenti si trovano coinvolti in episodi di prevaricazione, sia nei contesti scolastici tradizionali sia negli spazi digitali come social network e chat.
L’impatto di queste forme di violenza non è solo immediato, ma produce conseguenze psicologiche e relazionali profonde, che minano l’autostima, il rendimento scolastico e il benessere dei ragazzi. La diffusione del cyberbullismo, in particolare, ha reso il problema ancora più complesso, poiché amplifica la portata degli atti aggressivi, li rende persistenti e difficili da controllare. Per questo motivo, scuole, famiglie e istituzioni sono chiamate ad affrontare con urgenza questa sfida, promuovendo percorsi di educazione al rispetto, inclusione e cittadinanza attiva.
- Guarda anche l’articolo sul Piano nazionale per l’educazione al rispetto: cos’è e come funziona a scuola
Il bullismo
Il termine bullismo deriva dall’inglese bullying, che a sua volta proviene da bully, parola usata nel XVII secolo con il significato di “prepotente” o “prevaricatore”. Inizialmente, però, in inglese bully indicava anche un “compagno caro” o “amico”, e solo nel tempo ha assunto il valore negativo con cui è conosciuto oggi.
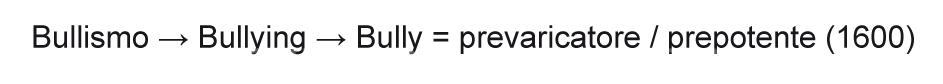
In italiano, la parola è stata introdotta nella seconda metà del Novecento per descrivere quei comportamenti di prevaricazione intenzionale, sistematica e ripetuta che un individuo o un gruppo esercita ai danni di una vittima più debole.
L’uso del termine si è diffuso soprattutto negli anni ’90, in concomitanza con studi pedagogici e psicologici sul fenomeno nelle scuole.
👉 Oggi, il concetto di bullismo non si limita al contesto scolastico, ma si estende a tutti gli ambienti sociali, includendo anche il cyberbullismo, nuova forma di aggressione resa possibile dalle tecnologie digitali.

Il bullismo è dunque un comportamento aggressivo, ripetuto nel tempo, messo in atto da uno o più individui nei confronti di una vittima percepita come più debole o incapace di difendersi.
Gli elementi principali che lo caratterizzano sono:
Intenzionalità: l’azione è deliberata e non casuale.
Ripetizione: gli episodi non sono isolati, ma si ripetono nel tempo.
Squilibrio di potere: chi compie il gesto ha un vantaggio (fisico, psicologico, sociale) rispetto alla vittima.
Il bullismo può manifestarsi in diverse forme:
fisico (spinte, botte, danneggiamento di oggetti),
verbale (insulti, minacce, offese),
relazionale o sociale (esclusione dal gruppo, diffusione di voci, isolamento),
cyberbullismo (uso di social, chat, messaggi o video per colpire la vittima).
Le conseguenze del bullismo possono essere gravi: ansia, depressione, calo del rendimento scolastico, isolamento sociale, perdita di autostima. Per questo è considerato un fenomeno da contrastare con azioni educative, prevenzione e sostegno psicologico.
Il cyberbullismo
Il termine cyberbullismo nasce dall’unione della parola inglese cyber (che rimanda al mondo digitale, alle reti informatiche e a internet) e bullying (da bully, “prepotente”), cioè “bullismo”.
➡️ Letteralmente, quindi, significa bullismo elettronico o digitale, ed è usato per indicare tutte le forme di aggressione, molestia o prevaricazione che avvengono attraverso strumenti tecnologici: social network, chat, e-mail, forum, videogiochi online.
Il concetto si è diffuso a partire dagli anni 2000, parallelamente all’aumento dell’uso di internet e dei cellulari tra i più giovani.
Il cyberbullismo, a differenza del bullismo tradizionale, ha caratteristiche proprie: anonimato, rapida diffusione dei contenuti e assenza di limiti di tempo e spazio, che rendono più difficile difendersi e più durature le conseguenze psicologiche sulla vittima.
👉 In sintesi, l’origine del termine mette in evidenza come la tecnologia abbia trasformato un fenomeno antico, il bullismo, amplificandone gli effetti e rendendolo un problema sociale ancora più complesso.
Il cyberbullismo è una forma di bullismo che avviene tramite strumenti digitali come social network, chat, e-mail, forum o videogiochi online.
Si distingue dal bullismo tradizionale perché sfrutta la rete per amplificare e rendere costante l’atto persecutorio.
Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono:
Anonimato: spesso chi agisce si nasconde dietro profili falsi.
Diffusione rapida: foto, video o messaggi offensivi possono circolare in pochi secondi e raggiungere un vasto pubblico.
Assenza di limiti spazio-temporali: la vittima può essere colpita in qualsiasi momento, anche al di fuori della scuola o del gruppo sociale.
Persistenza: i contenuti diffusi online possono restare a lungo in rete, rendendo difficile rimuoverli del tutto.
Esempi di cyberbullismo:
insulti e minacce tramite chat o social,
diffusione di foto o video imbarazzanti senza consenso,
creazione di profili falsi per deridere qualcuno,
esclusione intenzionale da gruppi virtuali (cyber-ostracismo).
Le conseguenze possono essere gravi: ansia, isolamento, calo del rendimento scolastico, fino a veri e propri traumi psicologici. Per questo motivo il cyberbullismo è considerato un fenomeno sociale di forte rilevanza e in Italia è stato affrontato con la Legge n. 71/2017, che prevede misure specifiche di prevenzione e tutela per i minori.
Bullismo e Cyberbullismo
Scheda Informativa
Il bullismo e il cyberbullismo sono forme di prevaricazione intenzionale e ripetuta caratterizzate da uno
squilibrio di potere tra aggressore e vittima. Il primo si manifesta soprattutto in presenza (scuola, strada, gruppi),
il secondo usa strumenti digitali (social, chat, e-mail, giochi online) che amplificano la portata e la persistenza degli attacchi.
| Caratteristica | Bullismo | Cyberbullismo |
|---|---|---|
| Definizione | Comportamento aggressivo intenzionale e ripetuto in presenza, con squilibrio di potere. | Aggressione e molestie online tramite strumenti digitali; stessi elementi chiave, ma in rete. |
| Contesto | Scuola, spazi pubblici, sport, gruppi di pari, famiglia allargata. | Social network, chat, e-mail, forum, piattaforme di gaming, gruppi/messaggistica. |
| Mezzi | Fisico (spinte, botte), verbale (insulti), relazionale (esclusione). | Messaggi offensivi, doxing, diffusione di immagini/video, profili fake, esclusione digitale. |
| Caratteristiche chiave | Visibilità circoscritta al luogo; intervento di adulti più immediato. | Anonimato, viralità, assenza di limiti spazio-temporali, contenuti persistenti. |
| Esempi | Spintoni, minacce faccia a faccia, umiliazioni davanti al gruppo, danneggiamento di oggetti. | Insulti in chat, condivisione non consensuale di foto, hate speech, gruppi per deridere la vittima. |
| Segnali nella vittima | Lividi/oggetti rovinati, paura di andare a scuola, isolamento, calo del rendimento. | Ansia all’uso del telefono, cancellazione profili, ritiro sociale, disturbi del sonno, ipervigilanza online. |
| Conseguenze | Bassa autostima, ansia, depressione, assenteismo, fobie sociali. | Effetti psicologici amplificati dalla persistenza e pubblicità degli atti online. |
| Prevenzione | Educazione al rispetto, sorveglianza negli spazi comuni, protocolli scolastici, coinvolgimento famiglie. | Educazione digitale, privacy impostazioni, segnalazioni/ban, tracciabilità delle prove, supporto psicologico. |
| Riferimenti | Linee educative su convivenza civile e piani anti-bullismo nelle scuole. | Legge 71/2017 sul cyberbullismo: tutela dei minori, rimozione contenuti illeciti, procedure scolastiche. |
| Cosa fare subito | Parlare con adulto/Docente referente, documentare episodi, attivare protocollo scolastico. | Salvare prove (screenshot, URL), segnalare su piattaforme, richiedere rimozione, informare scuola e genitori. |
Il Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto contrasto al bullismo
Il Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione (MIUR) introdotta nel 2017 con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto, della tolleranza e dell’inclusione all’interno delle scuole italiane.
Si tratta di un insieme di linee guida e azioni educative rivolte a studenti, insegnanti e famiglie per contrastare fenomeni come:
il bullismo e il cyberbullismo,
le discriminazioni basate su genere, orientamento sessuale, religione, disabilità, etnia,
la diffusione di stereotipi e pregiudizi,
la mancanza di rispetto delle differenze.
Il Piano si collega a principi costituzionali (art. 2, 3, 34 della Costituzione) e a impegni internazionali assunti dall’Italia, e si inserisce nel quadro più ampio dell’educazione alla cittadinanza attiva e ai diritti umani.
In pratica, nelle scuole vengono proposti:
percorsi didattici che favoriscono il rispetto reciproco,
attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere e l’omofobia,
progetti interdisciplinari su convivenza civile, parità e inclusione,
formazione dei docenti su metodologie inclusive.
👉 In sintesi, è uno strumento che mira a rendere la scuola un luogo in cui ogni studente possa sentirsi accolto e valorizzato, imparando il rispetto delle persone e delle differenze come valore fondamentale di convivenza civile.
- Guarda anche: Bullismo e cyberbullismo nel sito del Miur
Normativa contro bullismo e cyberbullismo in Italia
La normativa contro bullismo e cyberbullismo in Italia è stata rafforzata negli ultimi anni per tutelare i minori e promuovere una scuola inclusiva e sicura. Oltre alla Legge 107/2015, che impone alle scuole di inserire nel PTOF azioni concrete per la parità di genere e il contrasto delle discriminazioni, sono stati introdotti strumenti specifici come la Legge 71/2017 sul cyberbullismo, il DPR 235/2007 con il Patto educativo di corresponsabilità e la Legge 92/2019 che ha reso obbligatoria l’educazione civica. A queste disposizioni si aggiungono le Linee guida MIUR per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza tra pari. L’obiettivo comune è garantire un ambiente scolastico basato su rispetto, inclusione e cittadinanza attiva, proteggendo studenti e studentesse da ogni forma di prevaricazione, dentro e fuori la rete.