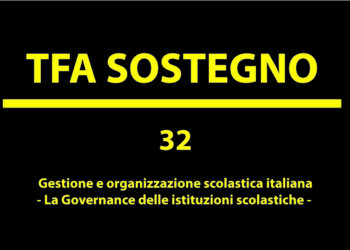Le origini: le scuole speciali e la separazione educativa
Fino agli anni ’60, gli alunni con disabilità venivano inseriti in scuole o classi speciali, separate dal contesto ordinario.
L’idea dominante era quella della “cura” e dell’assistenza più che dell’istruzione: la diversità era vista come un limite da isolare, non come una risorsa da valorizzare.
I modelli pedagogici dell’epoca, influenzati dalla medicina e dalla psicologia comportamentista, cercavano di “normalizzare” l’alunno con deficit piuttosto che adattare l’ambiente di apprendimento ai suoi bisogni.
- Guarda anche il TFA SOSTEGNO 32 – Gestione e organizzazione scolastica italiana: la Governance delle istituzioni scolastiche
Leggi anche: Capo Comino, la spiaggia tra le dune e il silenzio

Che cosa sono la psicologia e la medicina comportamentista
La psicologia comportamentista (o behaviorismo) è una corrente nata negli Stati Uniti all’inizio del Novecento, grazie a studiosi come John B. Watson e B.F. Skinner.
Essa sostiene che il comportamento umano possa essere compreso e modificato osservando le reazioni agli stimoli esterni, senza considerare direttamente i processi mentali interni.
Secondo questo approccio, l’apprendimento avviene attraverso rinforzi e punizioni: si premiano i comportamenti corretti e si scoraggiano quelli indesiderati.
Parallelamente, la medicina comportamentista applicava gli stessi principi al campo della salute e della disabilità, interpretando le difficoltà individuali come disfunzioni da correggere mediante interventi terapeutici o riabilitativi mirati.
In ambito scolastico, questo modello portò a privilegiare un approccio centrato sul controllo del comportamento e sulla normalizzazione dell’alunno, piuttosto che sulla personalizzazione dell’insegnamento.
Solo con l’evoluzione delle scienze dell’educazione e con l’affermarsi di visioni più umanistiche e inclusive si è passati da una logica “correttiva” a una pedagogia dell’accoglienza e della valorizzazione delle differenze.
L’influenza della psicologia e della medicina comportamentista sulle politiche scolastiche pre-riforma
Nel periodo precedente alle grandi riforme degli anni ’70, le politiche sociali e scolastiche italiane erano fortemente influenzate dai modelli medico e comportamentista.
La disabilità veniva interpretata principalmente come una condizione patologica individuale, da diagnosticare e trattare attraverso interventi terapeutici più che educativi.
In questo quadro, la scuola non era vista come un luogo di sviluppo globale della persona, ma come un contesto selettivo, destinato a chi rientrava nei canoni della “normalità”.
L’approccio comportamentista, diffuso nelle scienze psicologiche tra gli anni ’50 e ’60, portava a considerare l’apprendimento come un insieme di risposte a stimoli esterni: l’educazione speciale, quindi, puntava più sul controllo dei comportamenti che sulla valorizzazione delle potenzialità cognitive e relazionali dell’alunno.
Questo modello, pur con l’intento di fornire un sostegno mirato, finì per rafforzare la separazione tra alunni “abili” e “non abili”, legittimando la creazione di scuole e classi speciali.
Solo con l’affermarsi delle teorie umanistiche e socio-costruttiviste — che mettono al centro la persona, il contesto e la relazione educativa — si è aperta la strada alla pedagogia dell’inclusione, trasformando profondamente la visione educativa della società italiana.
🧠 Sintesi del comportamentismo
Origine: Stati Uniti, primi del ’900, con John B. Watson e B.F. Skinner.
Oggetto di studio: il comportamento osservabile, non i processi mentali interni.
Principio base: l’apprendimento è il risultato di stimoli e risposte.
Metodo: utilizzo di rinforzi positivi e negativi per modellare i comportamenti.
Applicazioni scolastiche: programmi educativi strutturati, ripetizione, premi e punizioni.
Limite principale: trascurava la dimensione affettiva, sociale e cognitiva dell’alunno.
Influenza sulle scuole speciali: ha favorito un approccio correttivo e separativo, centrato sul controllo del comportamento e sulla “normalizzazione” della persona con disabilità.
🏫 Sintesi della riforma dell’inserimento scolastico (Legge 517/1977)
Contesto storico: anni ’70, in un clima di rinnovamento culturale e sociale.
Obiettivo principale: abolire le classi differenziali e promuovere l’inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni.
Principi innovativi:
riconoscimento del diritto all’istruzione per tutti gli studenti;
collaborazione tra insegnanti curricolari e docenti di sostegno;
didattica flessibile e personalizzata;
valutazione qualitativa, non più solo numerica.
Nascita della figura dell’insegnante di sostegno, con competenze pedagogiche e psicologiche.
Effetti a lungo termine: inizio della scuola inclusiva italiana, riconosciuta come modello a livello europeo.
Limiti iniziali: carenza di risorse, formazione insufficiente e difficoltà di integrazione reale.
Gli anni ’70: la svolta dell’inserimento scolastico
Il vero cambiamento arriva con la Legge 517 del 1977, che abolisce le classi differenziali e introduce il concetto di inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni.
È una pietra miliare nella storia dell’inclusione italiana: da questo momento, la scuola si impegna ad accogliere tutti gli alunni, valorizzando le potenzialità di ciascuno.
Nasce anche la figura dell’insegnante di sostegno, professionista specializzato che collabora con i docenti curricolari per promuovere la partecipazione attiva dell’alunno in difficoltà.
Dall’inserimento all’inclusione: un cambio di paradigma
Negli anni ’90 e 2000, grazie anche alle Linee guida per l’integrazione scolastica e alla Legge 104/1992, si consolida un nuovo paradigma: quello dell’inclusione.
Non si tratta più soltanto di inserire un alunno “diverso” in classe, ma di trasformare la scuola affinché risponda ai bisogni di tutti.
L’approccio inclusivo coinvolge:
l’intera comunità scolastica;
la personalizzazione dei percorsi didattici;
la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio;
la progettazione educativa individualizzata (PEI).
L’inclusione oggi: una sfida ancora aperta
Oggi la scuola italiana è riconosciuta a livello internazionale per il suo modello inclusivo, ma le sfide restano: formazione continua dei docenti, risorse adeguate e una reale cultura della differenza.
Chi si prepara al TFA Sostegno 2025 deve comprendere che l’inclusione non è solo una materia di studio, ma una missione educativa che mette al centro la persona, non la disabilità.
Studiare la storia per costruire il futuro
Capire il passaggio dalle scuole speciali all’inserimento significa capire le radici dell’inclusione.
Ogni insegnante di sostegno porta avanti un percorso iniziato decenni fa, fatto di conquiste, leggi e cambiamenti culturali.
Studiare questi passaggi non serve solo per superare il test TFA, ma per diventare parte attiva di una scuola più giusta e accogliente.